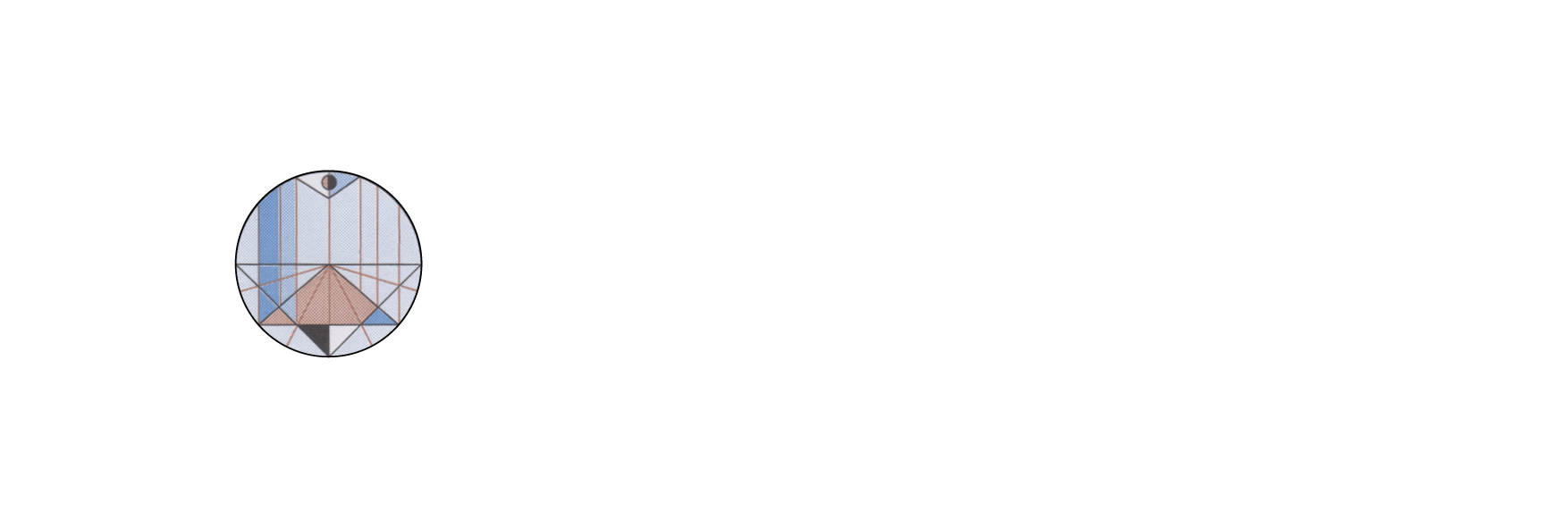Dal Manifesto di Ventotene alla disciplina del Diritto di Proprietà all’interno della nostra Costituzione

di Paolo Brescia – Consigliere nazionale Inrl
Nel dibattito attuale, è utile ricordare che la nostra Carta costituzionale, nasce da una sintesi tra culture politiche diverse: cattolica, socialista, liberale. La “limitazione” della proprietà privata, spesso evocata come minaccia, è in realtà una sua valorizzazione in funzione della collettività.
La lettura moderna dell’articolo 42 Costituzione non può prescindere dalla storia italiana: un Paese che ha saputo costruire benessere diffuso grazie anche a un uso intelligente del pubblico, senza negare l’iniziativa privata. In un contesto globale segnato da nuove tensioni economiche, catene di approvvigionamento instabili e l’introduzione di dazi commerciali sempre più aggressivi, la funzione sociale della proprietà privata può rappresentare un valore aggiunto. Quando i mercati si fanno turbolenti, la capacità di uno Stato di intervenire in modo coordinato, responsabile e in nome dell’interesse collettivo si rivela uno strumento di stabilizzazione e di protezione.
Questa visione si intreccia anche con un altro principio costituzionale: l’articolo 47, che afferma che “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.” Insieme, questi articoli formano un asse di protezione sociale ed economica, che guarda al cittadino non solo come consumatore o contribuente, ma come soggetto attivo e titolare di diritti economici.
E forse, nel richiamarsi al Manifesto di Ventotene, sarebbe utile ricordare anche questa lezione: la libertà e la crescita economica devono sempre camminare insieme alla giustizia sociale — e in tempi incerti, questi principi possono essere la chiave per affrontare il futuro con maggiore equità e resilienza.
Dal Manifesto di Ventotene all’Articolo 42: la funzione sociale della proprietà tra Costituzione, boom economico e pubblico interesse. Le recenti dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Manifesto di Ventotene hanno riacceso il dibattito sui valori fondativi dell’Europa e sul ruolo dell’Italia nella costruzione di una società più giusta, libera e solidale. Ma per comprendere appieno la portata di queste affermazioni, è utile tornare alle radici Costituzionali della Repubblica italiana e al modo in cui i padri costituenti hanno concepito il rapporto tra proprietà privata e interesse collettivo. La funzione sociale della proprietà: l’articolo 42 della Costituzione
La Costituzione italiana, promulgata nel 1948, non nega la proprietà privata, ma la inserisce in un quadro di responsabilità sociale. L’articolo 42 stabilisce che: “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, a enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.”
Questa norma, influenzata dalla cultura del tempo, risente profondamente dello spirito del Manifesto di Ventotene, scritto nel 1941 da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi durante il confino fascista sull’isola omonima. Il manifesto invocava una società europea libera dai nazionalismi, capace di superare l’ingiustizia sociale e garantire libertà e diritti ai cittadini. In questo contesto, la proprietà privata non era un dogma inviolabile, ma un diritto che doveva essere armonizzato con il bene comune. Il contesto storico: boom economico e partecipazione pubblica Nel dopoguerra, l’Italia affrontava sfide enormi: ricostruzione, disoccupazione, povertà diffusa. Ma fu proprio grazie alla visione di uno Stato attivo nell’economia che si gettarono le basi per il cosiddetto “miracolo economico” degli anni ’50 e ’60.
Un momento emblematico fu la nazionalizzazione dell’energia elettrica nel 1962, che portò alla nascita dell’ENEL come ente pubblico. Contrariamente a un’interpretazione puramente liberista, questa scelta fu vista come coerente con i principi costituzionali: lo Stato interveniva in un settore strategico, garantendo l’accesso all’energia a tutta la popolazione e orientando lo sviluppo industriale del Paese.
Non era una negazione del mercato, ma un atto di bilanciamento: la proprietà privata restava garantita, ma subordinata alla sua funzione sociale. In questo modo, la Costituzione non solo permetteva, ma in un certo senso legittimava interventi di interesse collettivo. E in questo momento, come non possiamo ricordare Papa Francesco che nel paragrafo 189 dell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium pubblicata il 24 novembre 2013, rimarcava e sottolineava la funzione sociale di qualunque forma di proprietà privata.
Dott. Paolo Brescia